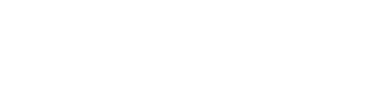Cento anni di storia della scienza

Winter School di Storia della Scienza
Firenze, Museo Galileo
24-28 novembre 2025
Le domande devono essere inviate entro le ore 24:00 CET del 15 luglio 2025
PARTECIPAZIONE GRATUITA
Il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza rappresenta una delle principali istituzioni a scala internazionale attive nella museografia scientifica, nelle attività di documentazione e di ricerca e nella realizzazione di iniziative per la diffusione della cultura scientifica.
La Winter School, organizzata nell’anno in cui ricorrono i cento anni dalla fondazione dell’Istituto di Storia delle Scienze (1925-2025), intende offrire ai suoi partecipanti una full immersion nella vita dell’istituzione fiorentina tra lezioni teoriche e attività pratica, con focus sulle collezioni museali e librarie del Museo Galileo e sulle attività di ricerca e di diffusione della cultura storico-scientifica dell’Istituto di Storia della Scienza.
Le lezioni, tenute da studiosi interni al Museo Galileo o che da tempo collaborano con esso, permetteranno di approfondire le principali linee di ricerca portate avanti dall’Istituto. Alle lezioni frontali seguirà una parte pratica, finalizzata a mettere in risalto i collegamenti con le attività del Museo, della Biblioteca, del Laboratorio Multimediale, dell’Unità Web e del Settore Mostre.
ORGANIZZAZIONE
La Winter School è organizzata dal Museo Galileo in collaborazione con la Società Italiana di Storia della Scienza (SISS).
OBIETTIVI
Obiettivo della Winter School è non solo fornire una formazione avanzata in storia della scienza attraverso lezioni, seminari e visite museali, ma anche offrire occasioni di confronto tra studiosi, operatori museali e studenti raccontando come funzionano un museo e un istituto di ricerca “dietro le quinte”.
PARTECIPANTI
La Winter School è aperta a dottorandi, post doc e giovani studiosi (età massima 40 anni), provenienti da università e istituzioni culturali in cui abbiano svolto ricerche pertinenti con la storia della scienza.
La partecipazione è gratuita.
Numero di partecipanti ammessi: massimo dieci, minimo cinque.
PROGRAMMA
La Winter School si articola in cinque giornate, suddivise in sessioni teoriche al mattino (10:00-12:00) e workshop al pomeriggio (14:30-16:30).
Il Museo Galileo proporrà inoltre visite esclusive a musei e istituzioni di Firenze e un momento conviviale tra docenti e partecipanti.
Il programma dettagliato verrà pubblicato in seguito.
La lingua di lavoro è l’italiano.
DOCENTI
ANTONIO BECCHI ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia delle Scienze e delle Tecniche nel 1994 presso l’Università di Firenze. Dal 1992 collabora al progetto internazionale Between Mechanics and Architecture avviato da Patricia Radelet de Grave e Edoardo Benvenuto. Tra il 1989 e il 2001 ha trascorso regolari periodi di ricerca a Bologna, Venezia, Berlino, Gottinga, Parigi (École Polytechnique e École Nationale des Ponts et Chaussées) e ha insegnato all’Università di Genova e all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV). Nel 2002-2024 è stato Visiting/Research scholar presso il Max-Planck-Institute for the History of Science (Berlino) lavorando ai seguenti progetti: Epistemic History of Architecture, Transformations of Antiquity/Transformationen der Antike, In-Camera-Out e Disiecta membra. Tracing the History of the Albani Libraries. Nel 2018-2019 è stato Visiting fellow presso il Warburg Institute (School of Advanced Study, University of London), dove attualmente è Associate fellow. Nel 2021 ha curato con Sabine Hoffmann, Jürgen Renn, Matteo Valleriani e Serge von Arx la mostra Leonardo’s intellectual Cosmos (Staatsbibliothek, Berlino). Dal 2010 fa parte del comitato editoriale della Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge; è membro corrispondente dell’International Academy of the History of Science (dal 2012), del consiglio di amministrazione dell’Association Francophone d’Histoire de la Construction (dal 2014) e, dal 2016, del consiglio scientifico della Werner Oechslin Library Foundation (Einsiedeln) e del Centro Urbino e la Prospettiva (Università di Urbino).
ANDREA BERNARDONI è Professore associato di Storia delle scienze e delle tecniche presso il Dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila, dove insegna Storia della scienza, Storia e filosofia della tecnologia, Storia e conservazione degli strumenti scientifici. Si occupa di storia della scienza e della tecnologia con particolare attenzione all’approccio metodologico di tipo sperimentale. Si è occupato di storia dell’ingegneria e della metallurgia in ambito medievale e rinascimentale, ricostruendo i processi di fusione di autori quali Vannoccio Biringuccio e Leonardo da Vinci. Collabora con il Museo Galileo e il Museo Leonardiano di Vinci, con i quali porta avanti progetti di filologia macchinale e Digital Humanities. È autore di numerosi saggi, tra cui la monografia Leonardo ingegnere (Carocci 2020) e Storia della scienza dal Rinascimento al XX secolo (con Marco Segala, Il Mulino 2024). I suoi interessi più recenti riguardano il vocabolario tecnico dagli ingegneri rinascimentali e la tecnologia del cantiere brunelleschiano dell’Opera del Duomo di Firenze. Principali linee di ricerca: Ingegneria e scienza del Rinascimento; Filologia macchinale: analisi e studio di strumenti scientifici, macchine e processi tecnici del passato; Digital Humanities: edizioni digitali dei manoscritti di Leonardo da Vinci e storiografia vinciana; Comunicazione dell’informazione tecnica tra gli artigiani rinascimentali.
FILIPPO CAMEROTA è Direttore scientifico del Museo Galileo. Ha insegnato Disegno e Storia dell’architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), dedicando la sua carriera di studioso alla storia delle ‘intersezioni’ tra arte e scienza, con particolare riguardo alla prospettiva rinascimentale. Tra le sue principali pubblicazioni sul tema della prospettiva si segnalano il catalogo della mostra Nel segno di Masaccio. L’invenzione della prospettiva (Firenze, Uffizi, 2001-2002), curata in occasione delle celebrazioni di Masaccio; il volume monografico La prospettiva del Rinascimento. Arte, architettura, scienza (Electa 2006); l’edizione critica del trattato di prospettiva di Lodovico Cigoli (Linear Perspective in the Age of Galileo, Olschki 2010); il catalogo della mostra Piero della Francesca: il disegno tra arte e scienza (con Francesco Di Teodoro e Luigi Grasselli, Skira 2015). Nel corso delle celebrazioni leonardiane ha curato la sezione sull’architettura del territorio per la mostra L’acqua microscopio della natura. Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci allestita agli Uffizi nel 2019. In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ha curato l’esposizione Dall’Inferno all’Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia (Firenze, Palazzo Pitti, 2021-2022). In ultimo, nel 2023 ha curato due mostre per i 400 anni del Saggiatore di Galileo: La Città del Sole: arte barocca e pensiero scientifico nella Roma di Urbano VIII (Roma, Palazzo Barberini) e Splendori celesti: l’osservazione del cielo da Galileo alle onde gravitazionali (Firenze, ex dormitorio di Santa Maria Novella).
ELENA CANADELLI è Professoressa associata all’Università di Padova, dove insegna Storia della scienza e Museologia naturalistica. È direttrice scientifica del Museo Botanico dell’Università di Padova e membro del Comitato scientifico del Museo Galileo e dell’Osservatorio sul Patrimonio Scientifico e Tecnologico del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Fa parte del National Biodiversity Future Center (NBFC), dove si occupa del coordinamento della digitalizzazione delle collezioni naturalistiche italiane, ed è editor-in-chief della rivista “Nuncius. Journal of the Material and Visual History of Science”. Dal 2021 è presidente della Società Italiana di Storia della Scienza. Si occupa di storia della scienza visuale e materiale, con particolare attenzione all’età contemporanea, di storia dell’evoluzionismo, storia dei musei scientifici e museologia scientifica. Ha curato mostre temporanee, tra cui Cristina Roccati (1732-1797). La donna che osò studiare fisica (Rovigo, Palazzo Roncale, 2024-2025), e allestimenti museali, come il percorso del Museo Botanico dell’Università di Padova aperto al pubblico nel 2023. Ha pubblicato numerosi libri e articoli, tra cui, da ultimo, la curatela Da cimeli a beni culturali. Fonti per una storia del patrimonio scientifico italiano (con Paola Di Lieto, Editrice Bibliografica 2024) e il saggio Il dibattito italiano sulle due culture. Ludovico Geymonat senza filtri, in “Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ‘900” (2024).
GIOVANNI DI PASQUALE è Vicedirettore scientifico del Museo Galileo, dove si occupa di storia della scienza tra Antichità e Medioevo. È membro dell’Osservatorio sul Patrimonio Scientifico e Tecnologico del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano e del comitato scientifico della rivista “Physis”. Per il Museo Galileo, in collaborazione con i principali musei archeologici italiani, ha curato una serie di mostre internazionali, tra cui Homo Faber. Natura, Scienza e Tecnica nell’antica Pompei (Napoli 1999; Los Angeles 1999; Monaco di Baviera 2000; Parigi 2001; Tokyo 2002); Vitrum. Il vetro tra arte e scienza nel mondo romano (Firenze 2004; Parigi 2005); Archimede. Arte e scienza dell’invenzione (Roma 2013; Trento 2017). La mostra Vitrum ha ricevuto nel 2006 il “Dibner Award for the Most Outstanding Exhibition”. Nel 2019 ha curato per il Museo Galileo, in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi, l’esposizione La Colonna Traiana. Costruire un capolavoro (Firenze, Palazzo Pitti, 2019; Roma, Parco Archeologico del Colosseo, 2024). Nel 2006 è stato short listed (secondo classificato) per la posizione di Head of Junior Research Group presso il Max-Planck-Institut for the History of Science di Berlino e nel 2021 è stato short listed nella selezione per Direttore del Parco Archeologico di Pompei. Ha tenuto oltre cinquanta conferenze in Italia e all’estero ed è autore di oltre settanta pubblicazioni tra monografie, curatele, articoli in riviste scientifiche. Il suo ultimo libro, Le macchine nel mondo antico (Carocci 2019) è stato finalista al “Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica”, istituito dal CNR e dall’Associazione Italiana Editori.
NATACHA FABBRI è dottore di ricerca in Filosofia (Scuola Normale Superiore, Pisa), diplomata in pianoforte e abilitata a professore associato in storia della scienza dal 2012; insegna Storia della scienza all’Università di Siena. È responsabile scientifico ed editoriale del portale “Scienza” per l’Ecosistema digitale della cultura della Regione Toscana, che prevede collaborazioni con circa trenta istituzioni scientifiche toscane. È stata borsista presso numerosi istituti di ricerca italiani e internazionali, tra i quali: International Balzan Prize Foundation, Villa I Tatti - Harvard University, University of California Los Angeles, Fondazione Ruberti. È membro del progetto europeo Cost Early Muse, del comitato di redazione delle riviste “Galilaeana” e “Mefisto”, del comitato organizzatore del Congresso Nazionale di Astronomia Culturale (INAF) e del collegio del dottorato AFAM in Arte, Tecnologia e Percezione. Al Museo Galileo è incaricata di ideare e sviluppare progetti di ricerca e di divulgazione sui rapporti tra scienza, musica e filosofia e tra donne e scienza. È stata ideatrice e co-curatrice della mostra Donne del cielo: da muse a scienziate (Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 2024). Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano le monografie Cosmologia e armonia in Kepler e Mersenne (Olschki 2003), “De l’utilité de l’harmonie”. Filosofia, scienza e musica in Mersenne, Descartes e Galileo (Edizioni della Normale 2008; vincitore del premio filosofico di Castiglioncello) e Profili di donne sulla Luna. Riflessi di scienza, filosofia e letteratura (Edizioni della Normale 2022); le curatele Copernicus Banned (con Federica Favino, Olschki 2018), Vincenzo Galilei. The Renaissance Dialogue between Music and Science (con Ferdinando Abbri, Olschki 2025), Women’s Voices in Renaissance and Early Modern Scientific Culture (con Meredith K. Ray, focus della rivista “Galilaeana”, 2025). Le sue ricerche si concentrano sulla filosofia e la storia della scienza del Rinascimento e dell’età moderna (principalmente storia dell’astronomia), i rapporti tra musica e scienza e l’impiego della musica in contesti museali, le questioni di genere nella scienza, l’opera di Galileo, Kepler, Copernico e Cartesio.
ALESSANDRA LENZI è responsabile del settore Biblioteca e archivi del Museo Galileo. Si è occupata della creazione e aggiornamento della Banca dati cumulativa, un archivio integrato che, fin dal 2006, raccoglie schede descrittive e risorse digitali relative a libri, manoscritti e documenti d’archivio, fotografie d’epoca e moderne, stampe e disegni, strumenti scientifici e medaglie, consentendo la consultazione integrata delle collezioni del Museo Galileo e di numerose banche dati prodotte nell’ambito dei vari progetti di ricerca. Cura la redazione di due progetti promossi dalla Società Italiana di Storia della Scienza e dal Museo Galileo: la Rassegna italiana di storia della scienza (dal 2021) e il Repertorio italiano delle tesi di dottorato di interesse storico-scientifico (dal 2022). Dal 2022 fa parte del Comitato di redazione del Portale Archivi della Scienza, ideato e diretto dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, di cui il Museo Galileo cura la sezione “Risorse bibliografiche”. Dal 2024 fa parte del Comitato di redazione di ABCSI – Archivio Biografico della Cultura Scientifica Italiana, progetto promosso da CNR-ILIESI, Società Italiana di Storia della Scienza, Università Roma Tre e Museo Galileo.
GIORGIO STRANO è dottore di ricerca in Storia della Scienza (Università di Firenze). Nel 2003 è divenuto Curatore del Museo Galileo, dove attualmente ha l’incarico di Responsabile delle Collezioni. Svolge attività di ricerca e divulgazione soprattutto nel campo della storia dell’astronomia e dei suoi strumenti dall’Antichità fino al Seicento. Ha pubblicato numerosi articoli su riviste di storia della scienza italiane e straniere e in volumi collettanei. Si dedica in particolare alle modalità di analisi, interpretazione e valorizzazione degli strumenti astronomici, nonché allo studio della loro struttura, uso, conservazione ed eventuale restauro. Fra i suoi contributi più recenti: A Look back at Galileo’s Telescopes, in I. Chinnici (ed.), Italian Contributions to Planetary Astronomy (Springer 2024) e Dalla nuova stella di Cassiopeia alle opposizioni di Marte: Tycho Brahe, la parallasse e una “insidiosa” teoria cometaria, in Il “Saggiatore” di Galileo a 400 anni dalla sua pubblicazione (Atti dei Convegni Lincei 2024). Ha collaborato alla realizzazione di mostre sulla storia della scienza, dell’astronomia e della strumentaria scientifica: Scienziati a Corte (2001), Machina Mundi (2004), La relatività da Galileo a Einstein (2005), Il telescopio di Galileo (2008-2009), Astrum 2009: Astronomia e strumenti da Galileo ad oggi (2010), Leonardo da Vinci e il moto perpetuo (2019-2020), Ore italiane: Orologi storici dalla collezione Del Vecchio (2023). È membro della Scientific Instrument Society e della Scientific Instrument Commission della IUHPST. Nel 2007 ha fondato la collana “Scientific Instrument and Collections”, edita da Brill, di cui è stato general editor fino al 2020 e tuttora membro del comitato editoriale internazionale.
DOMANDE
Le domande devono essere inviate a info@museogalileo.it entro le ore 24:00 CET del 15 luglio 2025.
I candidati e le candidate riceveranno un’email di conferma della ricezione della loro domanda entro sette giorni dall’invio e notizie sull’esito della loro domanda entro il 5 settembre 2025.
La domanda deve includere:
• un breve CV (allegato in formato PDF)
• una lettera di motivazione contenente indicazioni sulle esperienze accademiche e gli interessi specifici nell’ambito della storia della scienza (max 300 parole; allegata in formato PDF)
ALLOGGIO E PASTI
I candidati e le candidate ammessi alla Winter School riceveranno informazioni relative alla possibilità di alloggi in convenzione e ai pasti, ai quali dovranno provvedere in autonomia sostenendone i costi.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti che completeranno con successo la Winter School riceveranno un attestato di frequenza rilasciato congiuntamente dal Museo Galileo e dalla Società Italiana di Storia della Scienza (SISS).